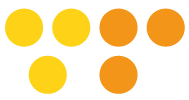ENSEMBLE TERRA D’OTRANTO

Venerdì 13 marzo - 21:00
Descrizione
Programma
Le prime informazioni della musica utilizzata per guarire i tarantati si trovano in opere del Medioevo: accanto agli Exempla di tradizione classica, cominciano a veder la luce diversi trattatelli, i De venenis, che cercano di approfondire l’argomento apportando ulteriori riflessioni sui poteri della musica, sulle cause del “male”, sul fenomeno osservato sul campo, sulle caratteristiche anatomiche della tarantola.
L’interesse per questo fenomeno vede nei secoli successivi un continuo crescendo, fino a giungere nel periodo Barocco in cui molteplici sono stati i contributi di medici, scienziati, filosofi, storici e musicisti. Non è casuale che la maggior parte delle partiture a noi giunte si riferisca proprio a quest’ultimo periodo. Se in passato la Pelandra, la Dama di Provenza, la Catena, la Guaracha, il Lepote, il Minuetto della Maschera di Cadice, ecc., venivano parimenti e variamente utilizzate, a partire dal Seicento la Tarantella diviene l’unica forma musicale presente nella terapia quasi a voler essere diventata la “summa” di tutte le altre: essa stessa si presenta in diverse forme e diversi “affetti” poiché i tarantati, e le stesse tarantole, non amano tutti la stessa melodia o la stessa pulsazione ritmica. Così abbiamo la tarantella in tono frigio, dal carattere vivace e travolgente, la tarantella in tono ipodorio, dal carattere austero, l´Antidotum tarantulae, dalla melodia languida e triste. Anche l’aspetto ritmico, come si diceva, presenta varietà: di base vi è un tactus binario ma gli accenti nelle pulsazioni sono sia binari che ternari (4/4, 2/4 e 6/8) a seconda del carattere della danza e del contesto geografico in cui venivano eseguite (in Spagna e nella zona di Napoli si utilizzavano i ritmi ternari, adatti a soavi danze, mentre in Puglia si preferivano quelli binari, di carattere vivace e ossessivo).
A partire dal XVIII secolo la funzione terapeutica della tarantella sopravvive soprattutto in Puglia e in alcune zone del Sud della Spagna. Nel resto del meridione d’Italia diviene una danza di corte o d’intrattenimento: a Napoli, ad esempio, venivano organizzati in piazza spettacoli per i turisti con finte tarantate e ricreate tarantelle. Da ciò ne conseguì una inevitabile “decadenza” sia nella varietà che nella forma. Straordinario, per certi aspetti, diviene il sopravvivere nel Salento, fino a tardo Novecento, della funzione terapeutica della tarantella: la danza assume la denominazione popolare di “pizzica”, dal morso della tarantola, e conserva gli stessi ossessivi elementi ritmici e melodici della antica forma. Essa diviene fulcro di un rito esorcistico e liberatorio di potente suggestione.
Doriano Longo
Lo spettacolo è stato presentato in diversi festival di musica antica e in convegni universitari sul tarantismo e sul potere di guarigione della musica. Nel 1999 la Provincia di Lecce ha patrocinato e finanziato la realizzazione di un CD sulle musiche utilizzate in Tarantule, Antidoti e Follie. Nel 2003 RAI Due TV ha dedicato ai contenuti dello spettacolo un cortometraggio all’interno della trasmissione Sulla Via di Damasco; il prodotto è stato premiato nel Festival Internazionale delle Produzioni Televisive di Varsavia, agosto 2003,
ricevendo la menzione d’onore. Nel 2010 l’Ensemble ha eseguito le musiche sulla terapia del tarantismo all’interno della Stagione Concertistica dell’Accademia di Santa Cecilia e della Stagione di Concerti del Teatro Olimpico di Vicenza. Nel 2019 lo spettacolo è stato presentato nel festival “Monteverdi” di Cremona.







.png)